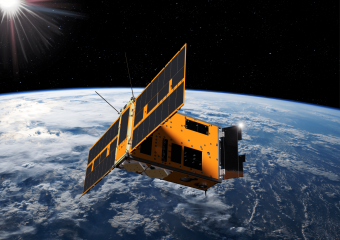Fonte: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1201
Domenica 10 luglio 2011
I. L’aggressione imperialista contro la Libia, capeggiata da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, ha posto una volta di più in primo piano il disorientamento imperante in buona parte della sinistra e nei “progressisti” di diverse sfumature, il cui pensiero e le cui opinioni appaiono modellati dall’egemonia ideologico-culturale del capitalismo, abbigliato per l’occasione con le vesti del derechouhumanismo.
Qualcosa di simile accadde durante le aggressioni contro Iraq e Yugoslavia: non bisognava condannarle, perché farlo implicava appoggiare dittatori come Saddam Hussein e Milosevich.
Non ci riferiamo qui all’attitudine dei socialdemocratici che appoggiano l’aggressione dal Governo (nei fatti, la Spagna di Zapatero e la Grecia di Papandreu, dissanguata dal capitale finanziario transnazionale) o dall’opposizione, come nel caso del Partito Socialista francese.
Alcuni gruppi e partiti che si autoproclamano di sinistra e anticapitalisti, hanno salutato la “primavera araba” in Libia e in seguito hanno precisato la loro analisi, denunciando l’aggressione delle grandi potenze, scatenata con il pretesto di “proteggere i civili”.
Altri gruppi e persone, anch’essi che si autoproclamano di sinistra – molto pochi, a questo punto della situazione, perché l’aggressione è diventata assai impopolare persino negli stati aggressori – mantengono il loro appoggio ai ribelli, però giustificano anche, in nome dei diritti umani del popolo libico, l’aggressione imperialista.
E accettano come verità irrefutabile la versione dei fatti trasmessa dai grandi monopoli di dis-informazione.
Gheddafi sarebbe un pazzo scatenato che ha saccheggiato il suo paese e ha i miliardi depositati nelle banche straniere. Quando le sue truppe si trovavano alle porte di Bengasi il Consiglio di Sicurezza decise di creare una zona di esclusione aerea sopra la Libia e immediatamente l’aviazione francese iniziò a bombardare le truppe di Gheddafi stazionate di fronte a Bengasi, evitando così il genocidio della popolazione, che pareva imminente secondo le informazioni delle grandi potenze e dei monopoli mediatici al loro servizio, sempre degni di fede per questi derechohumanistas con i paraocchi.
I ribelli, da parte loro, lotterebbero per i diritti umani, assetati di libertà e di democrazia, e non sarebbero un conglomerato eteroclito che include al suo interno anche ex alti dirigenti del regime, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.
II. La Libia è un paese quasi esclusivamente desertico, a eccezione di una stretta frangia di litorale (1770 km di costa), dove si trovano i principali nuclei di popolazione del paese.
Ha 6.500.000 di abitanti (un milione alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la maggior parte nomadi) e una superficie di 1.750.000 km quadrati. Attualmente Tripoli ha circa due milioni di abitanti, Bengasi un milione, Misurata 480.000 e Tobruk 200.000.
Possiede giacimenti petroliferi di qualità altissima, che costituiscono la sua quasi esclusiva fonte di risorse e si suppone che disponga di grandi riserve non sfruttate e ancora non scoperte.
L’altra sua ricchezza naturale è l’acqua. Sotto una superficie secca e quasi desertica, in quasi tutto il territorio esiste una gigantesca riserva di acqua fossile potabile stimata in 150.000 km cubi, chiamata Acquifero della Nubia, che copre circa due milioni di km quadrati e si estende in parte del Chad, dell’Egitto, della Libia e del Sudan.
Nel 1983 in Libia si cominciò un progetto di irrigazione, conosciuto come Grande Fiume Artificiale, per utilizzare queste riserve sotterranee al fine di portare alle città costiere più di cinque milioni di metri cubi di acqua al giorno. A tutt’oggi il Grande Fiume Artificiale somministra acqua potabile e per l’irrigazione al 70 per cento della popolazione, portandola dalla falda acquifera del sud alle aree costiere del nord, alle città di Tripoli, Tobruk, Sirte, Bengasi e altre. Con un costo stimato di 30.000 milioni di dollari, finanziato con la vendita del petrolio, la rete del Grande Fiume Artificiale, con quasi 5000 km di tubazioni da più di 1300 pozzi scavati fino a 500 metri di profondità e stazioni di pompaggio nel deserto del Sahara, ha come obiettivo anche quello di aumentare la superficie di terre coltivabili. Inoltre, l’acqua è molto economica: 35 centesimi di dollaro al metro cubo.
Impossessarsi di questa enorme riserva di acqua potabile è nella mira anche delle potenze imperialiste, mandatarie delle imprese transnazionali come la ex Lyonnaise des Eaux (Gruppo Suez) e altre, che hanno il controllo delle risorse idriche mondiali.
Se il proposito di Gheddafi fosse di annientare la popolazione di Bengasi, avrebbe a disposizione il semplice mezzo di tagliare la somministrazione di acqua alla città.
Dal 1990 il Programma delle Nazione Unite per lo Sviluppo (UNDP) pubblica un Indice di sviluppo umano, dove stabilisce una classifica dei paesi del mondo in base a vari parametri che rappresentano la qualità della vita delle persone, tra i quali l’istruzione, la speranza di vita, la salute e il reddito, e li differenzia per genere. Non tiene in conto i cosiddetti indici di libertà umana. L’indice 2010 include 169 paesi e la Libia occupa il posto 53 con un indice 75 (in ascesa rispetto agli anni precedenti), di una scala che ha un massimo teorico di 100. La Norvegia occupa il primo posto con indice 93. La Libia ha l’indice più alto dell’Africa, seguita a breve distanza da Algeria, Marocco e Tunisia, e in America Latina la superano solo Il Cile (78,3), l’Argentina (77,5) e l’Uruguay (76,5), che occupano rispettivamente i posti 45, 46 e 52. Messico e Cuba sono più o meno allo stesso posto della Libia.
Quindi la Libia è considerata un paese di medio sviluppo, raggiunto grazie a un buon utilizzo della sua rendita petrolifera, ma con un grave deficit in materia di diritti civili e politici, stimati in modo oggettivo, e soprattutto secondo i criteri di valutazione dei paesi occidentali “civili”.
III. Dopo la riconciliazione di Gheddafi con l’Occidente, le gravi carenze della Libia in materia di diritti civili e politici non hanno disturbato le grandi potenze, che hanno ricevuto in pompa magna il leader libico, ansiose di realizzare buoni affari, soprattutto l’ottenimento di concessioni petrolifere, la vendita di armi e da parte della Francia perfino l’offerta di costruire una centrale nucleare.
Si sono in questo modo concretizzate varie concessioni petrolifere e importanti vendite di armamenti.
Solo nel 2009 Gran Bretagna, Francia e Italia hanno venduto armi alla Libia per 25, 30 e 111 milioni di euro rispettivamente. Quello stesso anno, anche Malta figura nella lista dei venditori, per 80 milioni di euro. Malta non ha nessuna industria di armi ed è evidentemente solo un paese di transito. Da parte sua, la Francia ha tentato di vendere alla Libia gli aerei Rafale che fabbrica Dassault. Gli stessi che ora utilizzano per bombardarla.
Però Gheddafi è un individuo imprevedibile, che a quanto sembra cominciò a ideare la revisione delle concessioni petrolifere e a promuovere l’idea di autonomia finanziaria dell’Africa di fronte alle valute delle grandi potenze.
Inoltre, le riserve petrolifere e acquifere della Libia sono un bottino che stimola l’appetito degli aggressori. A questo bisogna sommare i depositi dello stato libico nelle banche straniere e le 144 tonnellate d’oro (circa quattromilaseicento milioni di euro), che sarebbero depositate nelle banche libiche.
Si capisce perché la “primavera” libica (preparata- sostengono alcuni- dai servizi segreti francesi, e probabilmente in parte spontanea) fosse una buona occasione per stabilire in Libia un governo “democratico”, cioè totalmente sottomesso alla voracità occidentale.
La ribellione non si è estesa a macchia d’olio, come speravano i portabandiera dei diritti umani, e si è dovuta utilizzare la foglia di fico di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza per intervenire militarmente a favore dei ribelli.
Intervento che può culminare in un’invasione terrestre, se non si fa sentire di più l’impopolarità nei paesi aggressori, non si accentua il dissenso in seno alla NATO e gli aggressori riescono a riunire le forze sufficienti. Questo darà per risultato instaurare il caos in Libia per molti anni, come in Iraq e Afghanistan, e convertire tutta la zona in una polveriera a causa della disseminazione degli armamenti, come ha ammonito qualche giorno fa il Presidente del Niger, Mahamadou Issoufou.
IV. Più di quattro mesi di bombardamenti aerei (e ora anche navali) ininterrotti: si tratta di una forma di terrorismo internazionale di Stato destinato a minare la morale del nemico, specialmente della popolazione civile.
L’Italia lo mise in atto in Etiopia nel 1935-36, Il Giappone in Cina nel 1937-39, la Germania e l’Italia durante la guerra civile spagnola (Madrid 1936, Guernica 1937), la Germania nazista e gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale (Varsavia, Rotterdam, Londra, Dresda, Hiroshima, Nagasaki, ecc.), gli Stati Uniti abbondantemente in Vietnam, Panama, Iraq, Yugoslavia, Afghanistan, e di nuovo in Iraq.
Centinaia di migliaia di lavoratori stranieri (di altri paesi di Africa e Asia) hanno dovuto fuggire dalla Libia, rimanendo senza lavoro e senza stipendio, con il quale contribuivano al mantenimento delle loro famiglie nei loro paesi di origine. L’economia della Libia è quasi paralizzata e le vittime civili dei “bombardamenti umanitari” sono numerose da entrambe le parti.
La costruzione a Tripoli di un nuovo quartiere di 25000 abitazioni è rimasta bloccata come conseguenza dell’aggressione.
Impossibile conciliare questi fatti con il preteso derechohumanismo di quelli che vogliono liberare la Libia da Gheddafi tramite internet o dai caffè di Parigi o di qualunque altra capitale Europea. Forse rimpiangono di non avere a disposizione anche loro i droni telecomandati degli yankee, per bombardare Gheddafi dal living di casa.
L’imminente genocidio della popolazione di Bengasi con il quale si è preteso giustificare l’inizio dei bombardamenti (di fatto l’aviazione anglofrancese si è convertita nella forza aerea di una delle parti di una guerra civile) è un argomento simile a quello delle “armi di distruzione di massa” in possesso di Saddam Hussein per giustificare l’aggressione all’Iraq.
Per la Royal Air Force non è la prima volta. Nell’ottobre del 1944, quando i tedeschi si stavano ritirando dalla Grecia, i comunisti greci e i loro alleati (l’ELAS), la forza più importante della resistenza contro l’occupazione nazista, controllavano Atene e potevano formare un governo. Il primo ministro inglese Churchill ordinò allora lo sbarco delle truppe britanniche in Grecia e il bombardamento da parte della RAF dei quartieri popolari di Atene per impedire l’accesso dei comunisti al potere. Il risultato fu che in Grecia si ristabilì la monarchia e si formò un governo di centro-destra.
Nel luglio 1956 il presidente dell’Egitto Gamal Abdel Nasser nazionalizzò il Canale di Suez. Nell’ottobre dello stesso anno Gran Bretagna (governo conservatore di Anthony Eden), Francia (governo socialista di Guy Mollet) e Israele (governo di Ben Gurion) aggredirono militarmente l’Egitto con il proposito di impadronirsi del Canale di Suez, ma, senza l’appoggio degli Stati Uniti, fallirono nell’intento.
V. I fatti sono così: ostinati.
Ma i teorici di sinistra con il ruolo di sostenitori dei diritti umani delle grandi potenze sostengono senza batter ciglio che i fatti confermano il loro punto di vista. E che quelli che chiudono gli occhi davanti alla realtà sono gli altri (sinistrorsi anacronistici “incollati ad antichi cliché”): “Bisogna andare contro la realtà, in altro modo la realtà si trasforma in un incubo molesto e la cosa migliore è opporvisi” (Abel Samir, “Siamo sicuri che sia il greggio, quello che ha spinto Obama alla guerra contro Gheddafi?”, Argenpress, 23 giugno).
Samir, in un articolo pubblicato il 13 giugno, già aveva scritto quello che segue:
“E questi di sinistra si sono costituiti in una pleiade di individui, partiti, organizzazioni, giornali, pagine internet, intossicati di slogan, cliché e dichiarazioni ampollose contro l’Impero nordamericano e i suoi alleati, senza considerare che questo impero in alcuni casi lotta in difesa dei diritti umani, anche se non lo fa per credo, ma per altri interessi nascosti, come il dominio geopolitico di una zona del mondo o la difesa della sua stessa posizione predominante in una zona nella quale ha dominato per molti decenni”.
Per giungere a questa conclusione, Samir, oltre a decretare, come fa, l’invalidità dell’analisi leninista dell’imperialismo nel secolo XXI, dovrebbe dimostrare che l’impero in alcuni casi agisce in difesa dei diritti umani. Non lo può fare. Di contro è facile dimostrare che l’imperialismo, yankee o altro, agisce SEMPRE contro i diritti umani, sia complottando contro e/o rovesciando governi progressisti o appoggiando dittature quando convenga ai suoi interessi.
Loro stessi lo dichiarano: gli Stati Uniti non hanno amici, hanno interessi.
Alcuni esempi di interventi imperialisti:
Intervento della CIA nel colpo di stato del 1953 in Iran contro il governo Mossadegh, che aveva nazionalizzato il petrolio; invasione del Guatemala nel 1954 tramite una forza armata promossa e finanziata dalla CIA e dalla United Fruit; invasione di Santo Domingo nel 1965; colpo di stato in Cile nel 1973; invasione di Granada nel 1983; invasione di Panama nel 1989; espulsione di Aristide da Haiti nel 2004 mediante azione congiunta di Stati Uniti e Francia. In Africa, nel momento della decolonizzazione sorsero leader come Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral e Jomo Kenyatta, che lottarono per una via indipendente per i loro popoli, contraria agli interessi delle ex colonizzatrici e delle loro grandi imprese. Tutti loro furono rovesciati o assassinati, come Lumumba e Cabral, e rimpiazzati con dirigenti dittatoriali, corrotti e fedeli alle grandi potenze neocolonialiste.
L’imperialismo aggressore e depredatore è la fase attuale che caratterizza il capitalismo nel suo insieme (quello che alcuni chiamano mondializzazione) e i suoi usufruttuari lo difendono con le unghie e i denti senza nessuna preoccupazione per i diritti umani dei loro propri popoli e meno ancora i diritti umani dei popoli altri.
Samir, nel suo articolo del 23 giugno, si dedica a “sviscerare la struttura economica e politica nella quale si sviluppano gli Usa”… “Allora, la classe dominante dell’Impero è raggruppata fondamentalmente in due partiti politici: i democratici e i repubblicani. Questi ultimi rappresentano gli interessi più reazionari di questo grande paese. Tra le sue file spiccano i proprietari delle grandi imprese petrolifere nordamericane, i rappresentanti politici di questi capitalisti o consorzi economici convertiti in imprese multinazionali o transnazionali. Specialmente le grandi imprese petrolifere. Quindi, se impadronirsi delle ricchezze petrolifere della Libia fosse stata la motivazione fondamentale per la partecipazione degli Usa nella guerra civile libica, al lato dei ribelli, questo partito repubblicano sarebbe, come è logico, il più interessato che gli USA si inserissero nella guerra e la vincessero il più tardi possibile”…
Sicuramente il ruolo del capitale industriale si è considerevolmente rinforzato durante l’amministrazione Bush, soprattutto quello delle industrie petrolifere e di armamenti. Nel governo Bush erano ampiamente rappresentate entrambe le industrie.
Con Obama il capitale finanziario ha recuperato il primato, ma ciò non autorizza a dire che ci siano interessi o strategie contradditori tra repubblicani e democratici, come non c’è contraddizione di fondo tra capitale industriale e capitale finanziario, poiché la fusione tra i due caratterizza la tappa imperialista del capitalismo e il sorgere delle imprese transnazionali, come già segnalato da Hilferding nel 1910 (Il capitale finanziario) e Lenin nel 1916 (L’imperialismo, fase suprema del capitalismo). Non bisogna dimenticare che con Obama il bilancio preventivo per le spese militari degli Stati Uniti ha continuato e continua ad aumentare.
Per cui non ha alcun senso sostenere che i repubblicani sono i falchi reazionari rappresentanti politici dei capitalisti e dei consorzi transnazionali e i democratici le colombe che difendono i diritti umani. Vale la pena rammentare che l’invasione di Bahia de Cochinos avvenne durante il governo democratico di Kennedy e che Clinton, anch’egli democratico, governava questo “grande paese” – come lo chiama Samir – quando gli USA promossero il colpo di Stato ad Haiti nel 1991, fece scatenare la guerra contro la Yugoslavia (Madeleine Albright, rappresentante di Clinton, fu quella che mandò a monte i negoziati di Rambouillet tra la Yugoslavia e l’Unione Europea) e iniziò la Guerra del Golfo.
Con il democratico Obama è cambiata la forma ma non la sostanza di questo tipo di operazioni. Il golpe in Honduras del 2009 fu criticato dal governo statunitense, che appoggiò le decisioni degli organismi internazionali (ONU e OEA) esigendo il ritorno del presidente in carica. Ma è incontestabile che senza il lasciapassare degli Stati Uniti il golpe non avrebbe avuto luogo, visto che detto paese ha il controllo delle forze armate dell’Honduras attraverso la sua base militare di Soto Cano, essenziale per la geopolitica sottoregionale degli stati uniti: da lì forniva appoggio logistico ai contras del Nicaragua durante il governo sandinista.
Samir sostiene che nel Congresso l’opposizione a continuare la guerra contro la Libia di una maggioranza di repubblicani e democratici si deve al fatto che considerano che non ci siano interessi statunitensi in gioco (solo propositi umanitari). Samir dimentica due cose: le prima è che negli Usa sono prossime le elezioni e i congressisti dovranno presentarsi davanti agli elettori e rendere conto anche di questa guerra, impopolare nonostante la scarsa partecipazione yankee. La seconda è che gli Usa rischiano l’insolvenza, con un debito di 15 miliardi di dollari.
È per questo che Obama, dopo aver lanciato un centinaio di missili Tomahawk sopra la Libia, a quanto pare con uranio impoverito, ha lasciato il carico principale dell’aggressione al suo alleato Cameron e al suo cagnolino Sarkozy “l’americano”, che ha fatto il calcolo sbagliato pensando che un blitzkrieg contro Gheddafi lo avrebbe fatto risalire nei sondaggi di opinione in vista delle prossime elezioni.
Samir scrive: “Quindi non sono mancati quelli che si chiedevano perché gli USA e la NATO non intervenissero anche in Arabia Saudita, Yemen, Siria e altrove. Di certo, gli USA e la NATO, sommersi fino al collo nel fango di Iraq e Afghanistan, non sono in condizione di infilarsi in altri pantani, a parte quello dell’intervento in Libia”.
Samir in parte ha ragione: gli imperialisti sono – dio sia lodato – impantanati.
Ma se non intervengono in Bahrein, Yemen e Arabia Saudita è perché si tratta di dittature amiche. In Bahrein è stanziata la Quinta Flotta della Marina yankee. L’Arabia Saudita, amica di sempre degli Stati Uniti, in marzo ha inviato truppe nel Bahrein per porre fine alle manifestazioni della maggioranza sciita.
Samir afferma: “I confronti armati tra le potenze che enunciò Lenin non avvengono più e si cerca l’integrazione degli stati in grandi entità di paesi in relazione tra loro secondo il modello della loro economia e, ovviamente, politicamente uniti, come la UE. Agli USA oggi non interessa altro che mantenere la supremazia, con l’interesse di dominare la politica mondiale e mantenere così, inoltre, sviluppo e progresso tecnologici ed economici di punta. Il confronto armato in questo modo sarebbe fuori luogo. Così oggi possiamo vedere che nel mondo ci sono quattro grandi formazioni di stati che si fanno largo nell’area politica ed economica, che non solo si rispettano le une con le altre, ma partecipano in qualche modo ai vantaggi del sistema capitalista”.
Le grandi potenze sarebbero in competizione rispettosa tra loro per mantenere supremazia e “sviluppo e progresso tecnologici ed economici di punta”, partecipando tutte “nei vantaggi del sistema capitalista”. Indubbiamente il capitalismo ha i suoi vantaggi… per quelli che si trovano sulla cuspide della piramide sociale.
Samir non si è reso conto che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sono morte 30 milioni di persone nei conflitti armati, o in guerre colonialiste intraprese direttamente dalle grandi potenze o in conflitti interimperialisti per il controllo delle risorse naturali dei paesi poveri, sotto forma di guerre locali. Secondo la rivista medica inglese The Lancet di gennaio 2006, solo nella Repubblica Democratica del Congo dieci anni di guerra civile sono costati la vita a milioni di persone (tra 3,5 e 4,5). Il Congo ha la disgrazia di possedere un sottosuolo enormemente ricco di materiali strategici. In Rwanda i genocidi di 800.000 persone furono consentiti dall’esercito francese in ritirata (Operazione Turquoise). Un gruppo di ricercatori dell’Università Brown ha appena pubblicato una valutazione del costo finanziario e umano delle guerre intraprese dagli Stati Uniti dal 2001 in Iraq, Afghanistan e Pakistan. Calcolano il numero di morti in azioni militari in 225.000, i dispersi in 8 milioni e il costo finanziario in qualcosa di più di due miliardi di dollari (vedere http://costsofwar.org/).
Samir aggiunge: “Quelli che considerano che la guerra oggi è il modo per fare buoni affari non sanno di cosa stanno parlando”.
Contrariamente a quello che afferma Samir, la guerra è un’opzione ricorrente del capitale monopolistico nei momenti di crisi economica, perché è un modo di riattivare la produzione industriale senza necessità di riattivare la domanda (lo Stato compra la produzione degli armamenti con i soldi dei contribuenti senza consultarli e la popolazione del nemico scelto “consuma”, certo involontariamente, le bombe che riceve sulla testa). Dopo la guerra, i grandi monopoli dell’industria civile si accaparrano l’affare della ricostruzione e degli “aiuti umanitari”.
Nel suo libro Capitalismo, Socialismo e Democrazia (1942) [1], l’economista Joseph Schumpeter affermava che “il capitalismo per sua natura è una forma o metodo di cambio economico”, di sostituzione del vecchio per il nuovo, che denominava “distruzione creativa” (nuovi consumatori, nuovi beni, nuovi metodi di produzione o trasporto, nuovi mercati, nuove forme di organizzazione industriale, ecc.). La guerra sarebbe la forma più drastica di “distruzione creativa” in seno al capitalismo.
Inoltre, l’industria degli armamenti è sempre interessata a collocare la sua produzione, a provare i suoi prodotti in condizioni reali (Guerra del Golfo, Yugoslavia, Afghanistan, aggressione all’Iraq, a Gaza, alla Libia…) e ad ampliare il suo mercato, per esempio tramite l’incorporazione di nuovi paesi alla NATO: il presidente del “comitato americano per l’ampliamento della NATO” è il vicepresidente della Lockeed Martin, impresa che occupa il secondo posto tra i più grandi fabbricanti e venditori di armamenti mondiali.
Secondo la relazione annuale dell’anno 2010 dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel 2009 le spese militari nel mondo sono salite a un miliardo e 531 mila milioni di dollari, il 6% in più del 2008 e il 49 per cento in più del 2000. La spesa militare del 2009 ha rappresentato il 2,7% del PIL mondiale dello stesso anno.
Sempre secondo il SIPRI nel 2008 si sono vendute armi nel mondo per 384 mila milioni di dollari, di cui 352 mila milioni, cioè il 90%, furono vendite effettuate da imprese degli Stati Uniti (230 mila milioni) e dall’Europa Occidentale (122 mila milioni).
VI. Samir sottoscrive la teoria – contraria alla realtà dei fatti – della denazionalizzazione del potere economico transnazionale e dell’emergenza di una sola classe dirigente mondializzata: “È molto difficile oggi sapere con esattezza a chi appartengano le grandi imprese multinazionali, essendo tante volte, come indica la loro stessa denominazione, capitali di molti paesi o di capitalisti di differenti nazioni e non sempre di un solo paese. Imprese che sembrano inglesi hanno capitali tedeschi, italiani, turchi, cinesi, giapponesi ecc… E così succede nella maggior parte delle imprese transnazionali. Il capitale oggi è più internazionale che mai. Perciò si dividono interessi di tutti i tipi, perché l’unica cosa che muove questi capitalisti è fare buoni affari e guadagnare il massimo possibile”.
Le classi dirigenti su scala mondiale convergono con l’obiettivo strategico principale di preservare il sistema, e allo stesso tempo competono ferocemente tra loro.
Le relazioni tra le società transnazionali sono una combinazione di guerra implacabile per il controllo dei mercati o di zone di influenza, di assorbimenti o acquisizioni forzate o consentite, di fusioni o accordi e dell’intento perenne ma mai conseguito di stabilire regole private e volontarie di gioco leale tra loro. Perché la vera legge suprema delle relazioni tra le società transnazionali è “divorare o essere divorate”.
Le società transnazionali sono versatili e poliedriche e cambiano nome frequentemente. Questo succede sia come risultato di fusioni o, anche se continuano a essere le stesse società, come un modo di tentare di farsi dimenticare dal pubblico dopo aver acquisito una cattiva reputazione a causa dell’intervento in crimini finanziari o economici o in gravi violazioni ai diritti umani.
Ma le fusioni, le delocalizzazioni e i cambi di nome non significano che le società transnazionali si siano convertite in enti virtuali e irreprensibili. Di sicuro la loro immagine si è via via depersonalizzata dal momento in cui si sono costituite come società anonime, rispetto all’epoca in cui un monopolio si identificava con un nome proprio (Rockfeller, Mellon, ecc.). Ma non c’è dubbio che anche oggi abbiano componenti reali e tangibili: capitale, sede legale, dirigenti responsabili, ecc.
Prova aggiuntiva alla loro esistenza, determinabile in coordinate spazio-temporali, è la loro presente influenza in organismi e meeting internazionali, con il ruolo determinante che esercitano negli orientamenti degli organismi finanziari internazionali e nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, attraverso i rappresentanti delle grandi potenze e delle loro equipe di giuristi ed economisti, e nell’influenza che esercitano negli orientamenti economico-finanziari e nella politica generale di quasi tutti gli stati del pianeta. La loro esistenza reale e tangibile si manifesta anche nel monopolio quasi totale che detengono sui mezzi di comunicazione di massa.
Possono avere sede in uno o più paesi: nella sede reale dell’entità madre, in quello degli impianti principali delle attività e/o nel paese dove la società è stata registrata, ma si può sempre identificare una nazionalità della società transnazionale, nel senso che c’è uno stato che la sostiene e difende i suoi interessi di fronte ad altri stati con mezzi politici, militari o altri.
E difende anche i suoi interessi negli organismi intergovernativi come l’Organizzazione Mondiale del Commercio, Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.
Il dato complementare che conferma la BASE NAZIONALE DELLE IMPRESE TRANSNAZIONALI: la crisi finanziaria ha mostrato come i governi delle grandi potenze abbiano destinato centinaia di migliaia di milioni di dollari per SALVARE LE PROPRIE BANCHE E NON QUELLE DEI VICINI.
Lenin continua ad avere, nei suoi punti essenziali, attualità assoluta.
Scriveva nel 1916: “Il capitalismo si è trasformato in un sistema universale di oppressione coloniale e di strangolamento finanziario della stragrande maggioranza della popolazione del pianeta da parte di un pugno di paesi “avanzati”. Questo “bottino” viene ripartito tra due o tre potenze rapaci di potere mondiale, armate fino ai denti (Stati Uniti, Inghilterra, Giappone) che, per dividerlo, trascinano tutto il mondo alla guerra”. (L’imperialismo, fase suprema del capitalismo. Prologo all’edizione francese e tedesca del luglio 1920, par. II).
VII. Conclusione
La violazione dei diritti umani delle persone e dei popoli è inerente al capitalismo nella sua fase imperialista. Come regola generale, le dittature sono sostenute e persino promosse dalle potenze imperialiste. E quando i popoli vogliono intraprendere il cammino della loro liberazione nazionale e sociale, le grandi potenze, che vedono minacciati i loro interessi e quelli dei capitali monopolistici che rappresentano, li aggrediscono con tutti i mezzi. Sono i fatti a provarlo. Di modo che l’asse fondamentale della solidarietà internazionale con i popoli che lottano per i loro diritti e libertà deve essere la lotta contro il capitalismo imperialista, nemico comune di tutta l’umanità. Rifiutando la trappola ideologica dell’imperialismo “umanitario”.
(Traduzione di Sara Ceratto)
[1] Etas, 2001
![Share on Facebook Facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()
![Share on Facebook Facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()